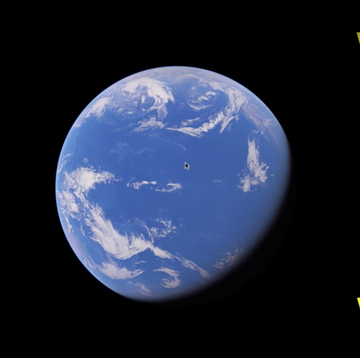Scrivo di città nei giorni in cui si sta consumando - inatteso e sconcertante - un nuovo urbicidio nel cuore dell’Europa. Ho negli occhi le immagini delle città ucraine, della capitale Kiev con la sua elegante architettura, le piazze larghe e piene di fiori, le strade ben curate; la guerra fa scempio dei corpi delle persone, delle loro anime ma si accanisce anche sulle città che le comunità hanno edificato, curato, trasformato nel tempo. La guerra distrugge tutto in una follia di cancellazione del nemico che è anche e sempre cancellazione della sua cultura e dei suoi luoghi di vita. E come possiamo noi cantare di città del futuro, di città sostenibili e sempre più adatte ad accogliere i nostri desideri di vita e di serenità, con il piede straniero sopra il cuore? Nel mezzo di questa furia distruttrice?
Avevo dimenticato questa parola terribile “urbicidio” pensando all’Europa, parola terribile coniata da un gruppo di architetti jugoslavi all’inizio degli anni Novanta, descrivendo quello che stava accadendo nel loro paese che andava in frantumi. È stata la guerra della mia giovinezza, quella a un passo da casa, la più vicina che potessi immaginare.
Oggi il mio cuore di madre si ferma di fronte alla sofferenza delle madri e dei figli, dei bambini e delle famiglie, dei ragazzi colti da un rigurgito violento della storia che nemmeno potevano immaginare, la mia testa di urbanista si sofferma sui giardini ben curati, i cordoli delle strade, le facciate restaurate, i grattacieli e i monumenti storici che si ergono dentro un tessuto elegante e arioso, prima della rovina, attraverso le immagini che arrivano dai media. Si cerca rifugio nel sottosuolo, nelle metropolitane, nei bunker, nelle cantine delle case, tristi “memorie del sottosuolo” si potrebbe dire ricordando Fedor Dostoevskij.
Le strade e le piazze sono tornate improvvisamente deserte. Quelle piazze che ci sono sempre parse smisurate, teatrali, straordinariamente fiorite e colorate, quei lunghi viali senza fine, simbolo della identità e della cultura di un popolo, progettate per il passeggio e il gioco, le sfilate di persone e le loro riunioni - come in tutte le grandi piazze di rappresentanza - oggi sono trasformate in “piazze d’armi”. Piazza dell’Indipendenza, per esempio, luogo del convenire e dove darsi appuntamento, dove i bambini giocavano intorno alle fontane, con i bar all’aperto sempre affollati, gli hotel più prestigiosi, le note delle sale da musica che uscivano dalle finestre. Piazze d’armi: non a caso esiste un nome per definirle, perché in questa guerra che ci riporta ad un passato che pensavamo lontanissimo, gli spazi grandi servono per fare passare carri armati e munizioni, per radunare le truppe.
Ma Kiev non è solo storia, musei della memoria, antiche Chiese e parchi storici. È anche la città che ha saputo proporre visioni al futuro, dove si sono sperimentate forme nuove di organizzazione degli spazi urbani. Il pensiero va a Comfort Town, quartiere iconico progettato dallo studio di architettura Archimatika e terminato solo nel 2019. Un quartiere dove piazze, spazi pubblici ed edifici si sono fusi in un gioco di colori e luce, di scorci poetici e visioni surreali. Il tutto rigorosamente lontano dal traffico delle macchine. Il colore che predomina sulle forme è nato dalla volontà di rendere felici gli abitanti, trasformando una vecchia area industriale in un quartiere giocoso e bello da abitare. Oggi tace anche Instagram che per anni ha raccontato questo luogo attraverso immagini liete di bambini per la strada, di campi da gioco tra le case, di spazi per lo sport. Colori pastello che sembrano uscire da un libro di fiabe perché l’architettura non può smettere di sognare e fare sognare la possibilità di una convivenza positiva e felice.
Non è facile pensare che quel mondo pieno di vita ed energia sia avvolto oggi dal grigio che tutto deturpa e stravolge di una guerra fuori dal tempo.
Sì, perché è proprio quando una città viene colpita così a tradimento che se ne coglie la imperfetta ma straordinaria complessità, il lavorio profondo che l’ha resa tale; a Kiev abitavano fino a pochi giorni fa quasi tre milioni di abitanti erediti di una storia lunga che nel tempo ha riplasmato luoghi, strade, case, chiese, costruito scuole e giardini, centri commerciali e musei. Le città sono davvero l’opera più alta e complessa che le società sanno realizzare, ma al contempo sono beni comuni e pubblici assolutamente fragili.
Ogni città è attraversata da trasformazioni continue, così impercettibili che fatichiamo a vedere. Si tratta di evoluzioni lente di cui ci accorgiamo solo tardivamente e con sorpresa quando la trasformazione è ormai avvenuta. Poi ci sono gli eventi imprevisti e radicali, quelli che non avevamo contemplato e che imprimono un segno più forte di cambiamento: una crisi economica, politica, una guerra, appunto, oppure - come stiamo vivendo in questi anni - una pandemia.
La pandemia che ha messo a dura prova le nostre sicurezze più profonde, che ha messo in discussione il nostro modo di lavorare e di abitare, trasformando tempi e luoghi della vita associata. Se aggiungiamo i cambiamenti climatici che hanno ripercussioni sulla tenuta dei nostri sistemi naturali, non possiamo che interrogarci con ancora più responsabilità - e vorrei dire con ancora più amore - sul destino dei luoghi che abiteremo.
Sono ore terribili, ancora in bilico, dove tutto può ancora succedere. E il senso del nostro poter vivere insieme in pace torna a interrogarci profondamente. Tutto quello che fa di-una-città-una-città viene sconvolto.
Mescolarsi tra la folla, cenare fuori con un amico, andare a un concerto o a una partita, giocare tra le case con l’occhio vigile delle madri dalle finestre delle case (come ci ha insegnato a osservare la giornalista e urbanista americana Jane Jacobs, che parlava di “occhi sulla strada”): ci accorgiamo di quanto sia straordinario fare cose ordinarie in città, solo quando questa possibilità ci viene a mancare. Amiamo vivere, pensare, incontrarci in quelle strade strette e dense di vita, attardarci nei bistrot e nei locali illuminati fino a tardi, prolungare le parole nella penombra delle piccole piazze.
Eppure, fare cose normali in un giorno qualunque, stare con gli amici a parlare fino a notte, non è privilegio e aspirazione solo delle più belle città europee. È la domanda legittima di ogni generazione, il senso profondo di ogni città.
Non sarebbe la normalità desiderata dai ragazzi di Beirut o di Damasco, di Gerusalemme o di Istanbul, di Atene e di Baghdad? Persino a Mosca e a San Pietroburgo, città oggi isolate dal mondo e tornate indietro ai loro peggiori incubi?
Sono passati solo pochi anni da quando Elizabeth Diller, oggi una delle più influenti architette al mondo, polacca di origine e arrivata bambina negli Stati Uniti, venne scelta per progettare Zaryadye Park nel centro di Mosca. È la stessa Diller a raccontare il suo dilemma morale: è possibile realizzare uno spazio pubblico democratico nel contesto di un regime repressivo? Può un parco diventare luogo di esperienza della libertà individuale e collettiva? Era il 2013 ma c’erano già tutti i presagi di quello che la Russia stava diventando.
Non a caso il progetto presentava vari vincoli imposti dalla committenza cittadina: doveva essere un grande parco ma evitare di creare spiazzi troppo ampi disponibili per assembramenti di persone; doveva intrecciare funzioni diverse ben precise ma anche suscitare meraviglia nelle persone. Il regime di Putin non ama le piazze, gli spazi di aggregazione, le persone che si radunano per manifestare pubblicamente il proprio dissenso; e anche un parco può diventare pericoloso, perché apre spazi di libertà e di associazione.
La ricerca di una libertà compositiva ha coinciso con il desiderio di creare uno spazio dove la libertà di movimento e di incontro fosse realmente sperimentabile dalle persone.
Il binomio rurale-urbano domina Zaryadye Park entro un canone estetico e funzionale non facile da definire: è un parco ma non è solo un parco. È allo stesso tempo anche una piazza urbana, uno spazio pubblico, uno spazio culturale e ricreativo (con padiglioni per esposizioni temporanee, anfiteatri e sale per concerti). Il parco è un ibrido stimolante di natura e artificio, che offre l’imprevista possibilità di calarsi in paesaggi lontani ma dentro la città storica.
C’è un’ordinaria felicità a cui tutte le città aspirano, da Kiev a Damasco, una felicità pubblica e civile, che si nutre di spazi pubblici ben curati, di parchi che ci mettono in relazione con la natura, di bar che affacciano su strada dove osservare i passanti, nel più ozioso dei rituali sociali. È quella felicità pubblica a cui tutti i popoli aspirano e che oggi vediamo messa nuovamente in pericolo, insieme alla libertà, alla democrazia, alla pace. Mancano le parole per dire l’abisso del nostro sgomento.